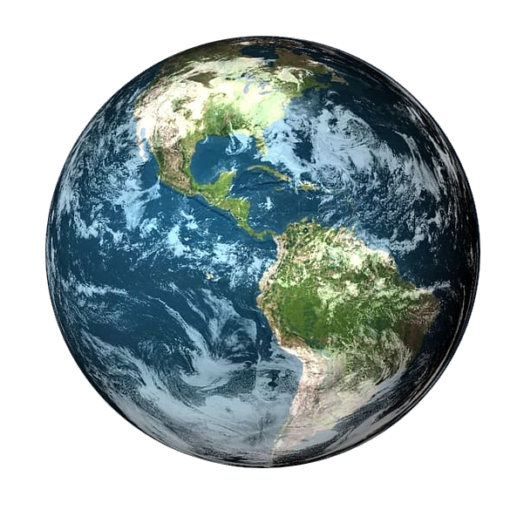DI ALBERTO BENZONI

Ancora alla fine degli anni novanta, il partito laburista israeliano era alla guida del paese e il suo leader, Ehud Barak, si recava a Camp David per discutere, con Clinton e Arafat, di un possibile accordo di pace. Ad appena vent’anni data questa formazione, unita ai socialisti di sinistra del Meretz, rappresenta intorno al 5% dell’elettorato, in una curva discendente che appare senza fine.
Le ragioni di questo disastro coincidono, anche se in forma molto più accentuata, con quelle che hanno portato al declino del socialismo europeo; elencarle tutte può dunque servire anche a noi.
La prima, e forse fondamentale, sta nella trasformazione della società israeliana. Sin dalle sue origini, il socialismo, intrecciato con il pieno recupero dell’identità ebraica, era l’asse portante del progetto sionista. Non a caso portato avanti dall’immigrazione proveniente dall’Europa centrale e orientale. Una specie di socialismo dal basso (kibbutz, cooperative, sindacati); i cui benefici erano però riservati soltanto agli ebrei. A differenza della destra, i palestinesi non erano considerati nemici permanenti, sensibili soltanto all’uso della forza; ma, semplicemente ignorati. Infine, c’era la convinzione che gli ebrei israeliani, avessero sempre bisogno di quella solidarietà internazionale mancata in passato ai loro confratelli.
Oggi Israele è, invece, una società capitalista avanzata con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. E il socialismo non è solo, come in Europa, scomparso dal futuro ma relegato in un passato di cui si sta perdendo la memoria e di cui sono venute meno le strutture portanti.
Per altro verso, il socialismo israeliano ha totalmente perso la sua dimensione internazionale. Nello specifico, legata all’essere o, almeno, all’apparire il partito della pace con i palestinesi. Sino a pagarne il prezzo con la morte di Rabin. Ora, appena cinque anni dopo, con il fallimento di Camp David e la successiva seconda intifada, il tema scompare totalmente dall’agenda; e in tutti i sensi. Ad occuparsi della guerra ma anche della pace saranno, da allora in poi, leader di destra, come Sharon o centristi, come Tzipi Livni e Olmert; ai laburisti, il concentrarsi sui temi del lavoro e della giustizia sociale. Ma qui i temi tradizionali si riveleranno assai poco se se non per nulla paganti. Per effetto del mutamento del “clima” (meno speranze e più paure). Ma anche perché, in generale, il socialismo non ha mai saputo rappresentare i ceti medi impoveriti e, ancor più, gli ultimi; gli uni e gli altri privi, in tutti i sensi, della necessaria coscienza di classe e della dimensione collettiva. Nello specifico poi, l’immigrazione, dagli anni sessanta in poi, contrariamente alle aspettative dei nostri compagni, ha nettamente favorito la destra populista. Gli ebrei provenienti dal mondo arabo, per tacere di quelli russi, essendo segnati segnati dall’ostilità esistenziale sia verso il socialismo reale che verso l’èlite socialista allora al potere; per tacere degli arabi.
Come si diceva, siamo qui di fronte all’esasperazione di fattori di crisi che investono, in maggiore o minor misura, tutta l’area del socialismo democratico.
Come risorgere, allora? O, più esattamente, come evitare di diventare irrilevanti in un terreno che i socialisti non hanno saputo coltivare, fino a vederlo occupato da altri; ma che, nel frattempo, è diventato oggettivamente sempre meno coltivabile?
I suggerimenti che continuano ad arrivare dal mondo intellettuale e accademico sono per lo più interessanti e pregevoli. Ma hanno due difetti, per ora insuperabili, relativi alla comunicazione ma anche alla sostanza del messaggio.
Nel primo caso, le riflessioni dei Piketty o degli Strauss Kahn (per citare solo due esempi) hanno molti pregi ; ma non a quello di com/muovere e ancor più di mobilitare i loro destinatari. Certo, i grandi profeti non nascono a domanda (e, questo vale anche per i socialisti). Ma il fatto è che il personale culturale e politico a disposizione non è in grado di suscitare energie e passioni comparabili a quelle alimentate della destra autoritaria e populista. E i rimedi suggeriti in proposito, diversi se non opposti nei contenuti, hanno in comune l’inefficacia.
Inefficace, per non dire irrilevante, il bollito scaduto del riformismo, leggi di un socialismo che parte dall’ordoliberismo ma non arriva da nessun’altra parte. Ma anche il ritorno all’ortodossia di una contestazione generale quanto generica, fatta di denunce che lasciano il tempo che trovano e della riproposizione di ricette spesso superate.
Naturalmente, tutte le mie simpatie vanno ai Corbyn e ai Sanders. Ma non al punto di pensare che, in un mondo dominato dalla paura e non dalla speranza, la loro capacità complessiva di suscitare adesioni sia superiore al loro effetto di rigetto.
E allora bisognerà assolutamente alzare il tiro. Non foss’altro perché siamo in una fase di transizione tra la fine del vecchio ordine e la faticosa e lontana nascita del nuovo; fase di incertezza e di disordine in cui la catastrofe è sempre possibile.
Ora, per risuscitare la speranza, c’è bisogno di un movimento che l’incarni. Che sappia contestare il capitalismo imbarbarito di oggi anche per la sua insufficienza sistemica. E che restituisca ai socialisti la capacità di partecipare in prima persona, anche se in un quadro e con scelte diverse dal passato, al movimento permanente dell’umanità in direzione di un mondo migliore.
Una rivoluzione copernicana; l’unica possibile.