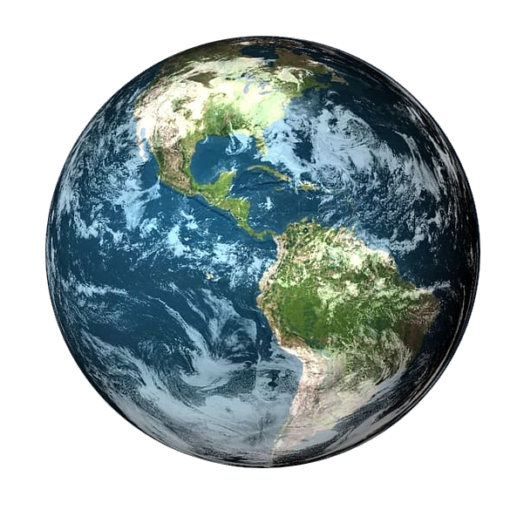DI ALBERTO BENZONI

Ho visto la mia prima partita nell’aprile del 1941. Fiorentina-Liguria 2 a 0. Da allora ne ho viste tantissime. E in tanti posti. In Francia (dove c’era il Red Star; ma giocava malissimo); in Ungheria (dove tifavo per l’Mtk , che giocava benissimo; ho scoperto solo dopo che era la squadra della polizia); in Inghilterra (Manchester United); e , naturalmente, in Italia. A Venezia con mio padre (Palazzo Ducale o Venezia-Pisa? Gli sciagurati risposero).A Sorrento, dove la partita si guardava in piedi al di là di una rete la squadra si chiamava Flos Carmeli. E a Roma, diventando romanista solo nel corso degli anni cinquanta (due scusanti: stavo all’estero e la Roma da me vista giocava malissimo, zeppa com’era di scartine e di ex campioni giunti dall’est, dove ne avevano viste di cotte e di crude). Da allora in poi ho visto ogni partita con eguale interesse: dal campetto di quartiere (“a quanto stanno?”) a Gabon- Burkina Faso.
Non abuserò della vostra pazienza raccontandovi delle infinite battute che ho avuto modo di ascoltare (ne citerò solo due: “a undici casi pietosi”- Roma sconfitta in casa- e “Alè, alè, alè, Herrera sul bidè”, Bologna-Inter 2 a 0 ). Perché è il momento di elevare il dibattito, domandandosi se il calcio senza o con pochissima televisione e con regole diverse fosse migliore di quello di oggi.
Lo era certamente nella sua capacità di coinvolgere; mentre, oggettivamente, era certamente peggiore.
Vedere le partite, così come sentirsele raccontare era, in modo diverso, eccitante. Entrare allo stadio era faticoso e talvolta impossibile. Come nella prima partita disputata a Roma dopo la Liberazione tra una selezione di giocatori locali e una di militari inglesi (3 a 1; una nuova disfida di Barletta?) dove, a respingere un’immensa folla, c’erano i carabinieri a cavallo. Come era impegnativo, all’Olimpico, vederla, in piedi e dove capitava. Ma, a ripagarti, la luce, i colori, i rumori, la gente, il cazzeggio amichevole con degli sconosciuti. E poi c’erano le sorprese e le incognite: gli arbitri, spesso pessimi al di là di ogni immaginazione ma anche caratterizzati, come i direttori d’orchestra, da stili molto diversi, a partire dalla concessione dei rigori. C’era chi non li dava mai; c’erano gli arbitri casalinghi. E chi si comportava in modo contrario, con il rischio dell’invasione di campo, e magari di inseguimenti al di fuori dello stadio. E, infine, c’erano la rozzezza e l’imprevedibilità del gioco: tutti in area e viva il parroco, palloni che stazionavano in aria (in un Roma-Lucchese, per quasi un minuto), squadre materasso, ma anche stili di gioco molto diversi, con l’emergere a sorpresa di nuove tattiche e di nuovii protagonisti in nuovi continenti. Rozzi, scarni e imprevedibili anche gli stadi, specie in Inghilterra: un edificio a prima vista simile a quelli che lo circondavano salvo per il fatto che la gente entrava e che, all’ingresso, c’erano matrone che vendevano pesce con patatine fritte.
Per la stragrande maggioranza delle “partite invisibili” (come quelle del grande Torino o della grandissima Ungheria) c’erano poi i giornali che enfatizzavano tutto: dai tiri alle parate, dalle prodezze di singoli giocatori che, sino alle immancabili ingiustizie subite in trasferta dalla squadra della città.
E mi fermo qui. Perché quel calcio eccitante era anche segnato dalla violenza e dall’arbitrio.
Una violenza non solo “esistenziale”. Come nelle serie inferiori (“oggi giochiamo da voi; ma domani voi giocherete da noi”; così disse un giocatore di una squadra siciliana a un collega campano; una constatazione ma anche un avvertimento) o tra squadre di antica rivalità. Ma anche, e per lungo tempo, negli stadi.
Ma a questa andava aggiunta anche la violenza organizzata, a livello di grandi società come di nazionali. Da una parte gli scarpari di professione; il cui motto è perfettamente rappresentato dalla battuta di Montero (“dalle mie parti possono passare la palla o il giocatore; tutti e due no”); dall’altra i Puskas, i Pelè, i Maradona, i Totti, i Riva e tanti altri. Per gli autori di falli criminali, la squalifica; per gli altri la fine della stagione se non della carriera; per le società colpite la perdita del giocatore e il dovere giocare la partita in dieci .
A coronare il tutto la violenza delle polemiche… che, alimentate da errori arbitrali smaccati, in cui non c’era modo di stabilire chi aveva ragione e chi torto.
Con la televisione, le nuove regole, la sentenza Bosman, e l’internazionalizzazione del sistema, tutto è però cambiato. Più noia, magari. E, anche, partite giocate con gli stessi schemi, giocatori che danno sempre le stesse risposte a domande altrettanto scontate, perdita di ogni radice locale, livello medio più elevato ma solo per la crescita di quello più basso e così via. E poi, la mazzata finale della pandemia. A fronte di tutto questo, però, maggiore possibilità per tutti, squadre e giocatori, di vincere qualcosa e comunque di partecipare. Maggiori tutele per gli attaccanti. Incentivi per le vittorie e per i gol. Stranieri con uguale e magari maggiore senso di appartenenza alla squadra e alla città. Minori isterismi e minori violenze. E, in Italia, ma non solo, maggiori possibilità di competere, con l’attenuamento notevole del fattore campo e, già che ci siamo, almeno in prospettiva, del fattore danaro.
Anche per queste ragioni, apprezzo il calcio senza spettatori. E lo apprezzo anche perché vedo che i giocatori si scusano dopo un fallo, si confrontano senza timori, parlano con l’arbitro e rispettano i loro avversari. E, per concludere, rimango convinto che, almeno in questo campo, nulla sarà come prima.