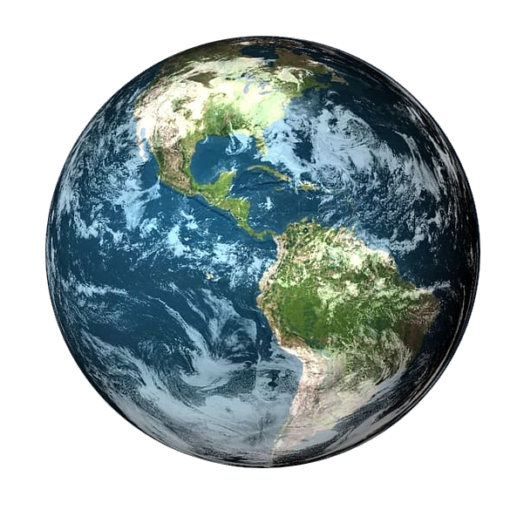DI ALBERTO BENZONI
Avevo proposto, poco tempo fa, soprattutto ai compagni del Psi , una moratoria volontaria di un anno sull’uso del termine “riformismo” e “riformista”. Ma mi sono reso conto, dopo “ampie consultazioni”, che stare zitti per un anno, per dei politici che campano solo di parole, sarebbe stata una pena eccessiva, anche perché volta a umiliare il reo, anziché a redimerlo.
Propongo dunque che chiunque usi le due parole incriminate, sia munito di un marchingegno che gli chieda “ma in che senso?” e lo obblighi a rispondere.
A questo riguardo tengo a dire che non ho nulla contro la parola; anche perché il riformismo è stata ed è l’unica strategia a disposizione per un partito socialista che non abbia nulla che fare né con la rivoluzione, né con la sinistra parolaia, né con l’accettazione supina della società attuale. Mentre ho molto da dire con quelli che la usano a sproposito e a fini puramente strumentali.
Per cominciare, una coincidenza curiosa. Leggi, il fatto che, nei primi trent’anni della nostra repubblica, e proprio quando le riforme, tutte o quasi tutte, oggettivamente, “di sinistra” (anche nel senso di realizzare progressivamente gli obbiettivi indicati nella Carta costituzionale), sono sempre all’ordine del giorno, la parola viene usata con parsimonia, di più con cautela. Mentre, nei periodi più recenti, quando di riforme di sinistra se ne fanno pochissime e di destra una gran quantità, questa stessa parola viene ripetuta sino alla noia.
Un atteggiamento comprensibile nel caso dei socialdemocratici: le istituzioni che, fino all’arrivo del fascismo, erano il simbolo visibile dell’emancipazione pacifica del proletariato (comuni, municipalizzate, leghe, case del popolo, cooperative) sono state, diciamo così, acquisite dai comunisti, che ne faranno un uso che più riformista non si può, guardandosi bene, però, e per ovvi motivi, da usare la parola. In quanto ai socialdemocratici, riformisti non saranno mai: e per l’impossibilità materiale di esserlo; e, soprattutto perché Saragat darà al partito il compito specifico di sentinella a sostegno della democrazia. Anche a danno della sua naturale identità.
Riformisti non erano nemmeno i comunisti. Perché usare la parola avrebbe nuociuto alla loro immagine; ma soprattutto perché tendevano a esaltare le conquiste fatte da loro e, a svalutare come insufficienti quelle fatte dal centro-sinistra e promosse dai socialisti. I più ideologicamente forbiti tra loro arrivarono a ridimensionare l’idea stessa di riforme di struttura come calate dall’alto o magari suscettibili di essere “riassorbite dal sistema”, a differenza delle politiche redistributive, destinate, così si diceva, a rafforzare il potere del Movimento operaio e, con esso, dello stesso Pci.
Tutte riforme di sinistra. Tutte riforme nella cui elaborazione i socialisti, ad ogni livello, avevano avuto un ruolo importante. Tutte riforme alla cui realizzazione avevano contribuito molti altri, comunisti compresi.
Ma, al tempo stesso, tutte riforme da cui i socialisti non avevano tratto alcun beneficio (e questo passi; quel 9.6% corrispondeva al 9.6% di Mancini nel 1972; e lo stesso Craxi, dopo il 9.9% del 1979 avrebbe faticosamente raggiunto l’11.3% nel 1983). Mentre i comunisti erano saliti di 7/8 punti; e questo era intollerabile.
“Abbiamo scosso l’albero e i comunisti hanno raccolto i frutti”. Di qui a dire che il vecchio gruppo dirigente l’avesse fatto scientemente non c’era che un passo. Di qui a dire che l’intero periodo, grandi riforme comprese, dovesse essere riposto in un cassetto o, peggio, bollato come “anni di piombo” sarebbe stato il successivo. Per chiudere con il convegno del 1981, dove la corrente di Craxi, da “autonomista” divenne “riformista”. Il che significava due cose. La prima era che il “partito di prima” era condizionato da idee e frequentazioni che lo rendevano, magari inconsapevolmente, etero diretto. La seconda, che la parola “riformista”, da allora in poi, avrebbe avuto, per i socialisti, un significato diverso.
In sintesi, si invertiva il rapporto tra partiti e società o meglio tra politica e società. Prima, spettava alla politica (e in particolare alla sinistra) fare valere il suo ruolo di intellettuale collettivo per cambiarla. Nella nuova versione la rivoluzione era, invece, nella società; a noi, dunque, il compito di seguirne il corso, per favorirlo o per correggerlo. Un limite ben presto varcato sottolineando che il riformismo non era lo spartiacque tra sinistra e destra ma piuttosto tra modernità e conservazione. Il che equivaleva a dire, in parole povere, che il nemico da battere non era la destra della conservazione e del privilegio ma piuttosto il Pci, le sue parole d’ordine, la sua visione del mondo e i suoi canali di penetrazione nella società.
Bersaglio legittimo in una logica di revisionismo. Bersaglio improbabile in nome del riformismo. E non a caso il craxismo vive nella memoria come progetto revisionista; ma senza che nessuno sia in grado di rappresentarlo come epoca di riforme.
Dopo la tragedia, la confusione diventa assoluta. Anche perché il partito scompare dalla scena e, con esso i vincoli derivanti dal rapporto con la realtà. Da allora l’evocazione del diventerà un passpartout, funzionale alle più diverse operazioni politiche. O, peggio, come una parola d’ordine necessaria per essere ammessi negli alloggi del protettore di turno. Il tutto mentre il nostro paese, lungi dall’essere bloccato dai sempiterni conservatori diventa la cavia di una riformite acuta, con l’unica conseguenza di renderlo definitivamente irriformabile. E ingovernabile.
Di riflesso, la nostra totale perdita di identità e disciplina collettive, lascerà ognuno libero di dire ciò che vuole per nasconderla.
Così, e questa è l’ultima tappa, il sostantivo socialismo deve essere sempre accompagnato da un aggettivo che ne attenui la portata e il significato. Il primo, quello di cui ci occupiamo qui è riformo; una parola il cui valore identitario è, per inciso, uguale a zero; figuriamoci poi se usata in polemica con i “ritardi” degli ex comunisti che ci hanno, tra l’altro superato di gran lunga nella corsa verso destra.
Leggo, infine, in questi giorni che la ricerca di aggettivi giustificativi continua: aggiungendo all’ormai logoro riformismo anche “liberale “e “repubblicano”. Un uomo della strada, magari ricordando i nomi dei partiti della prima repubblica, potrebbe stupirsi della assenza dell’aggettivo “democratico”.
Ma noi, uomini di mondo, abbiamo capito l’antifona: leggi che l’obbiettivo dell’operazione non è quello di qualificare il sostantivo ma di cancellarlo. Del resto, perché tenere in piedi l’insegna quando la merce è scomparsa dal negozio?