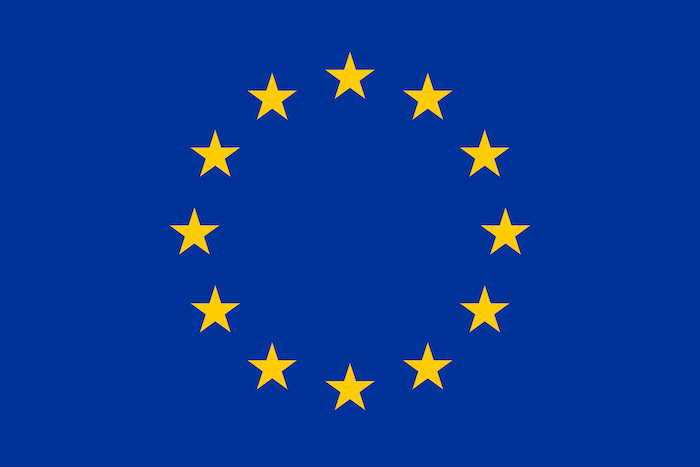DI ALBERTO BENZONI
Andare avanti. Più Europa. Anzi, una nuova Europa, non solo economica; ma anche politica e militare. Questo auspicano gli europeisti senza se e senza ma: dai sacerdoti di Bruxelles a quelli che ne lamentano l’assenza ma senza interrogarsi sulle sue ragioni. E, soprattutto, senza suggerire rimedi minimamente realistici.
Nel frattempo, però, cominciamo a pagare sempre di più i vizi di costruzione del nostro edificio; suscettibili di determinarne non diciamo il crollo ma l’inagibilità. In un processo di degrado favorito da un clima psicologico collettivo di segno opposto a quello esistente, nel periodo a cavallo tra il secolo scorso e il nostro. Passando dalle generose aperture di allora a un generale diffondersi delle paure: della pandemia, dei complotti, del “russo sotto il letto”, del migrante, della perdita d’identità, della decadenza, del caos che preme alle frontiere, di un futuro se non peggiore assolutamente incerto, della guerra. Paure spesso irrazionali e fomentate ad arte in un costante avvelenamento dei pozzi. Ma, non prive di fondamento.
E questo anche perché viviamo in un mondo privo di regole. Traversato da conflitti di ogni tipo, nessuno dei quali sembra vicino a risolversi. E soprattutto segnato da una caduta drammatica della legittimità e della credibilità delle istituzioni e dei governanti: incapaci di trasmettere qualsiasi messaggio dall’alto, anche perché incapaci di cogliere quelli che vengono dal basso o da mondi diversi dal loro.
In questo universo di riferimento, l’Europa non si percepisce più, non può percepirsi più, come nella seconda metà del secolo scorso, come centro del mondo, vetrina da esibire o oggetto del desiderio; mentre si sente sempre più marginale.
Anche per questo motivo, per riprendere il cammino occorrerà cambiare registro. Prendendo atto che le fughe di lato (leggi Brexit) non giovano a chi le pratica e non sono più all’ordine del giorno. E che, soprattutto, l’approccio funzionalista (in parole povere l’idea che la creazione di un organo, determini automaticamente la sua operatività), su cui è stata costruita l’Europa economica, non può assolutamente essere riproposto per far nascere quella politica e militare. Mentre l’esperienza recente dimostra l’esatto contrario. A partire dalle esperienze e dalle proposte oggi in campo.
Come è noto, l’Ue ha, da tempo, un Alto rappresentante per la politica estera. Ruolo occupato, sino a oggi, da personalità rispettabili più che autorevoli. Una scelta non casuale ma voluta. Come esemplificato, e nel modo più brutale, da Matteo Renzi che, oltre a non ricandidare Emma Bonino alla Farnesina, mandò in Europa non l’ingombrante D’Alema ma la volonterosa Mogherini.
Ora, però, si è voluto voltar pagina. Optando per un peso medio-massimo, lo spagnolo Josep Borrell. Senza però ampliare il suo raggio d’azione che, come descritto dallo stesso Borrell, consiste nel verificare dopo ampie consultazioni se esista, tra i 27 una “communis opinio”, suscettibile di essere rappresentata all’esterno. Missione, a detta dello stesso Borrell, estremamente faticosa. E forse, con il vincolo dell’unanimità, impossibile. Come ha avuto modo di verificare i Nostro, regolarmente richiamato all’ordine nelle sue proposte di dialogo con Putin o con i talebani così come nei suoi propositi di mediazione attiva in Venezuela.
Venendo poi ai problemi della difesa, possiamo segnalare l’improvvisa resurrezione del progetto di esercito europeo, sinora bloccato sul nascere non solo dalla naturale contrarietà della Nato ma anche dalla freddezza degli Stati uniti.
A farlo risorgere, come nelle favole, il “bacio in fronte” di Biden. Uno dei tanti dispensati ai suoi interlocutori nel suo recente viaggio in Europa. E nel caso, specifico, una semplice autorizzazione a procedere. Non certo un appoggio preventivo e incondizionato.
Forse proprio per questo, il progetto è doverosamente modesto. Prevedendo la creazione di una, diciamo così, forza speciale composta da circa 5 mila uomini e destinata ad intervenire, con la rapidità necessaria, in imprecisate situazioni di crisi.
È lecito, però, chiedersi, a questo punto, quali potrebbero essere i “casus interventi”. E chi avrebbe un concreto interesse a metterli in campo.
Un’aggressione esterna? Ma per questo c’è la Nato; a coprire tutti i fronti e a garantirci anche contro, diciamo così, invasioni improprie, come quella dei migranti (salvo, curiosamente, a non essere chiamata in aiuto dalla Polonia, dopo l’aggressione ordita da Lukashenko). Repressione di rivolte interne, modello Santa alleanza? Guai solo a pensarci. E, allora, rimangono soltanto le crisi interne a paesi esterni all’ambito Nato; ma a queste hanno già provveduto i paesi vincitori della seconda guerra mondiale, e solo loro, in Libia e nel Sahel. E, per inciso, con l’Italia nella veste di cobelligerante. E, allora, nell’attuale assenza di altre situazioni di crisi esterne che non siano già ampiamente monitorate e che possano coinvolgere altri paesi europei, rimane solo l’ipotesi di cambiare nome, aggiungendo nuovi partecipanti (vedi Sahel) alle iniziative già in campo. Poco, pochissimo; e nulla che possa servire al progetto di un’Europa, oltre che politica, militare. Anche, perché, in un’Europa a 27, la regola dell’unanimità, bloccherebbe sul nascere qualsiasi progetto. O, quanto meno, come accade per molti interventi affidati ai Caschi blu, ne rallenterebbe la messa in opera, sino renderla del tutto inefficace.
Tutto ciò ci riporta al tempo presente. E ai dossier oggi sul tappeto. E, in primis, a quelli pendenti da gran tempo e diventati sempre più pressanti: attinenti all’economia e alla finanza, ai diritti civili, come alla gestione del fenomeno migratorio. Così da verificare, su ognuno di questi, che l’incapacità di andare avanti ci porta a retrocedere sempre più rapidamente.
Così, nel primo caso, il sistema di Maastricht, con i suoi obbiettivi, le sue regole e i suoi meccanismi sanzionatori è stato, come dire, congelato, sino a risultare oggettivamente inoperante per tutta la durata di una crisi, insieme economica e sanitaria assolutamente devastante. E in cui il ruolo e la libertà di movimento degli stati sono cresciuti in modo esponenziale.
Naturalmente, chi dichiara di sospendere l’operatività di un sistema, e per forza maggiore, lo fa perché si riserva di ripristinarlo, dopo il ritorno alla normalità. Sta di fatto, però, che, dopo l’uscita dal tunnel, nulla sarà più come prima: obbiettivi da raggiungere in materia di debito e di deficit irrealizzabili; criteri usati per raggiungerli improponibili; centralità del ruolo degli stati in una prospettiva di crescita e di riduzione delle disuguaglianze, ineludibile.
Non mancano, però, i sostenitori del ritorno al passato. Molto probabilmente non in grado di far rinascere il vecchio sistema; ma anche, molto probabilmente, perfettamente in grado di impedire che se ne formi uno nuovo. Una situazione di paralisi; con la spinta sempre più forte al fai da te dei singoli stati. Ostacolato, ma non più frenato dagli interventi di Bruxelles.
Dei diritti civili si è già detto. C’è solo da aggiungere che la vertenza Est/Ovest assume per un verso i caratteri, del tutto arbitrari, di uno scontro di civiltà; mentre la rimessa in discussione e della democrazia liberale e del regime parlamentare investe, simultaneamente, sia pure con un’entità molto diversa, i due lati della vecchia cortina di ferro.
Un fenomeno, quest’ultimo, che si ripropone, ma in modo molto più drammatico, nella gestione del fenomeno migratorio. In cui siamo passati, nel giro di appena trent’anni, dal paradiso, magari un tantinello artificiale, all’inferno reale. Allora avevamo due categorie di migranti, tutte e due positive e rassicuranti. Il lavoratore pronto ad arrivare a richiesta e, se del caso, a ritornarsene nel suo paese. E, per altro verso, il rifugiato politico venuto d’oltrecortina.
Oggi, il lavoratore, quello disposto a svolgere a fare le tantissime cose “che gli…non vogliono più fare”, esiste eccome. Ma, stranamente, non è più una figura di riferimento; e questo perché il “senso comune” – leggi l’immaginario collettivo forgiato da una lunga serie di avvelenatori di pozzi – è arrivato a negare l’evidenza stessa. Leggi, il fatto che non foss’altro che per ragioni demografiche, il ricorso al lavoro e all’intraprendenza degli immigrati è una assoluta necessità.
Nel contempo, l’immagine del profugo ha subito un drammatico e vergognoso deterioramento. Al principio, poveretti da accogliere. Oggi, almeno nella versione polacca, criminali, pervertiti e potenziali terroristi da respingere. Ma, attenzione, il tutto con il consenso/assenso delle autorità europee alla costruzione di migliaia di chilometri di muri, sia pure a spese dei singoli; silenzio/assenso che comprende anche il diritto di usare le più moderne procedure di respingimento.
Mentre l’onda cresce si alza la diga. Fino a quando?
Siamo qui alla manifestazione estrema di una situazione di stallo su tutti i dossier in discussione. Ma non certamente di equilibrio. Perché, in tutti questi casi, vengono premiati coloro che rifiutano le regole e che si oppongono ai cambiamenti; penalizzati coloro che vogliono andare avanti verso la costruzione di una nuova Europa a dimensione politica, garante dei diritti fondamentali dei suoi cittadini e, nel contempo protagonista nella costruzione di nuovo ordine mondiale.
Come superare, allora, l’impasse?
Allo stato, l’unica via percorribile sembra quella del superamento del criterio di unanimità; che è poi in sostanza la fine del diritto di veto. Almeno sulle questioni di indirizzo generale. Una proposta, ovviamente, difficilmente traducibile in termini formali e che troverebbe, quasi sicuramente, una fortissima opposizione, nei paesi dell’est, ma non solo. Ma che avrebbe il vantaggio di garantire ai suoi promotori, se bocciata, una soluzione alternativa: l’utilizzo, non solo sulle questioni economiche ma anche su quelle attinenti alla politica estera e, più in generale, alla nostra proiezione internazionale, del criterio della cooperazione rafforzata, aperta a tutti gli stati che intendano avvalersene, per potere andare avanti.
Vengono automaticamente alla mente, a questo proposito, lo sviluppo dell’Unione economica sulla base di politiche comuni e di non semplici regole di concorrenza. E ancora, una serie di iniziative finalizzate al dialogo e alla distensione internazionale, come anche ad una gestione collegiale con i paesi d’origine del problema del fenomeno migratorio.
Ma fermiamoci qui. Perché sognare è giusto; ma senza esagerare.