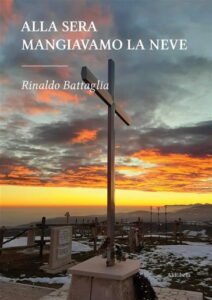DI RINALDO BATTAGLIA

Claudio Sommaruga – forse il più importante storico italiano degli IMI, gli Internati Militari Italiani, e di certo degno di credito essendolo stato in ben 13 lager nazisti, dal 9 settembre ‘43 al 22 aprile ‘45 – nel suo ‘1943/1945 Schiavi di Hitler’ – un giorno bene spiegò il fenomeno dei ‘prigionieri’ al tempo del Terzo Reich, focalizzandosi sul crimine di allora in terra di Germania e la colpevole ignoranza di oggi in terra d’Italia.
“Gli schiavi italiani furono in tutto 1.000.000, di cui 716.000 i cosiddetti internati militari (IMI) iniziali, 44.000 deportati nei KZ (i lager di sterminio tramite il lavoro), 170.000 lavoratori liberi civili (volontari e precettati) ed infine 78.000 altoatesini emigrati, che avevano optato per la nazionalità tedesca, ma riscopertisi italiani a guerra perduta”.
Furono un milione gli italiani coinvolti dopo l’8 settembre’43, schiavizzati dai nazisti col diretto e convinto – convintissimo – appoggio dei fascisti di Salò. E nessuno oggi ne sa nulla. Qualcuno a sua difesa dirà che Claudio Sommaruga sia di parte, in quanto personalmente coinvolto, ma a monte resta sempre vero il concetto che la Storia contemporanea non è scritta dai vincitori o peggio dai vinti, ma dai documenti. E se i documenti non sempre sono facili di analisi, almeno per chi non vuol capire, agli ignoranti resterebbero sempre pagine di altri affermati studiosi e storici per sanificare le loro lacune. Del resto, come scriveva a suo tempo Milan Kundera “le persone sono anche responsabili di ciò che decidono di ignorare”.
Furono un milione gli italiani usati come schiavi dai nazisti col supporto dei nostri fascisti. Com’è possibile che nessuno oggi in Italia ne sappia nulla e poco o nulla se ne parli? A quel tempo sul finire del ‘43 e nel ‘44, gli “schiavi di Hitler” non valevano niente, erano “vuoti a perdere”, “utensili usa e getta”. I tedeschi li chiamavano ‘stuck’ ossia ‘pezzi’ e come pezzi o numeri vennero gestiti ed usati. Se avevano un valore era il prezzo con cui le aziende agricole e peggio le fabbriche (le fabriken) prendevano in ‘noleggio’ – oggi diremmo col classico ‘rent a man’ – uno schiavo dai vari lager per 170 marchi fissi ‘una tantum’ e con durata fino alla sua morte oppure – alternativa preferita dagli imprenditori (i meister ossia i padroni) – a 6 marchi al giorno. In ogni caso potevi usarli senza limiti di orario (mediamente 12 ore ma anche 18 al giorno per ogni santissimo giorno del mese).
Il pagamento ‘a giorni’ era maggiormente scelto dai ‘meister’ perché evitava di ripagare altri 170 marchi quando uno ‘stuck’ moriva. Strano davvero dirlo oggi: 170 marchi era il costo di neanche 30 giorni di lavoro. Evidentemente in certe ‘fabriken’ si durava meno. Se uno schiavo ‘rendeva’ al lager quindi 6 marchi al giorno non poteva mancare il controllo ferreo dei costi. Il mantenimento in vita degli schiavi non doveva pesare mai cadauno oltre 0,60 marchi al giorno + 0,10 di spese varie di sussistenza. Qui nella contabilità del Terzo Reich si intendeva il costo dei vestiti, ma questa era solo una spesa teorica che permetteva solo ai comandanti degli Arb.K.do (campo di lavoro) di lucrare qualcosa per uso e consumo proprio. Crimine su crimine.
In altre parole ogni deportato nei lager rendeva per ogni singolo giorno, per 7 giorni alla settimana (non sempre e non dappertutto vi era una giornata o almeno un pomeriggio di riposo) e per 30 giorni al mese, 5.30 marchi al Terzo Reich, arricchendo ovviamente per primi i meister, gli imprenditori tedeschi. Non solo i gerarchi del Fuhrer.
Talvolta, soprattutto nei primi anni di guerra, il ‘costo di vita’ di uno ‘stuck’ veniva quantificato in massimo 2 marchi. Poi la guerra prese una piega negativa per la Germania e già con l’arrivo di Herbert Friedrich Wilhelm Backe al ministero dell’Alimentazione (o ‘della fame’ come diceva con più poesia il Fuhrer) nel maggio ‘42 si tagliò il costo e non a caso lo ‘sterminio’ dei prigionieri tramite il lavoro si velocizzò da allora in poco tempo. Numeri alla mano durante la guerra, dalla fine ‘39 al ‘45 Hitler, usò ben 13 milioni di schiavi ‘stranieri’ soltanto tra prigionieri di guerra e politici, per sostituire i ‘suoi’ tedeschi che il ‘suo’ regime spedì al fronte. Ben 13 milioni.
Non serve essere dei matematici alla John Nash per capire il risultato della resa. Tutti si arricchivano, mentre gli altri – gli schiavi – venivano sterminati tramite il lavoro. Ma se si partisse dalla primavera 1933 – quando il 22 marzo divenne operativo il primo lager nazista a Dachau, solo dopo 50 giorni che Hitler prese il potere – il numero totale si attesterebbe in oltre 25 milioni. E tra questi anche 2.300.000 di tedeschi contrari al nazismo, senza tener conto dei prigionieri razziali, ebrei in particolare. Numeri pazzeschi, difficili quasi da quantificare.
In quegli anni l’Italia ‘di allora’ (con l’Istria, la Dalmazia ed il Dodecanesimo) vantava tutta intera neanche 45 milioni di abitanti. Di questi 25 milioni ben 9 erano prigionieri di guerra, sovietici soprattutto (oltre 5.3 milioni di cui il 70% moriranno nei lager), 8 milioni deportati razziali e altri 4,5 prigionieri ‘politici’. Il resto erano, per 4 milioni scarsi, semplici ‘lavoratori’ obbligati al lavoro coatto in Germania o ‘rastrellati’ nelle azioni naziste nei territori occupati, quasi sempre con la collaborazione dei locali. Come da noi i fascisti del Duce, ai tempi neri di Salò.In tutte le stragi nazi-fasciste della nostra guerra civile ‘43/’45 – con oltre 25 mila morti – infatti il fenomeno dei ‘rastrellamenti’ fu imponente. Numeri veramente spaventosi. Il tutto sempre con il forte e convinto aiuto dei fascisti. Senza il loro fattivo apporto questo crimine non sarebbe di certo potuto accadere, almeno in queste terribili dimensioni.
La X Mas di Junio Valerio Borghese, gli squadroni di morte M Mussolini, la feroce Tagliamento di Merico Zuccàri, furono i leader in questo massacro. Ma non solo, anche semplici funzionari o federali fascisti delle varie zone, come a Marzabotto dove le S.S. vennero guidate dagli uomini del Duce, Lorenzo Mingardi e Giovanni Quadri. E così in ogni angolo d’Italia, sottomessa dopo l’8 settembre ancora al fascismo di Mussolini, ora ‘culo e camicia’ col Fuhrer, peggio e più di prima. Le stragi nazi-fasciste in Italia servivano per scovare i renitenti (i giovani classe 1924/1925 e 1926) che non volevano combattere col Duce, rompere il cordone ombelicale che univa i partigiani con le famiglie contadine stanche di 20 anni di fascismo, terrorizzare i paesi ma, e soprattutto, trovare nuovi schiavi per i lager e le fabriken del Terzo Reich. Qui le esigenze, soprattutto nel ‘44, erano fortissime: nei lager morivano troppi deportati e così troppi buchi bisognava subito coprire, specialmente dopo che i Russi da principale fornitore di schiavi erano diventati principale causa della loro, prossima, sconfitta. E tra le terre occupate nel Centro-Nord Italia l’Emilia e la zona di Bologna ebbero purtroppo un ruolo privilegiato.
Solo la strage di Marzabotto e Monte Sole di fine settembre‘44 nasconde – tra gli oltre mille morti individuati di cui almeno 115 bambini – i 5.000 bolognesi rastrellati nell’anno o – se si preferisce allargare il cerchio – i 20.000 emiliani. In questo scenario va inserito l’eccidio del 30 agosto 1944 – un mese prima Marzabotto – di 12 partigiani fucilati al Poligono di tiro di Bologna. Il giorno dopo i due principali giornali della città – a quel tempo gestiti dagli uomini ovviamente di Mussolini – «il Resto del Carlino» e dell’«Avvenire d’Italia» – pubblicarono a 9 colonne che giustizia era stata fatta contro “i responsabili di attività terroristica e sovversiva, compiuta il giorno precedente presso il Poligono di tiro, quale rappresaglia per l’uccisione del coll. della GNR Elio Zambonelli e del ten. col. dell’esercito Pasquale Vetuschi”.
Ma chi erano i due militari fascisti e chi i 12 partigiani? Il colonnello Zambonelli della G.N.R. è stato considerato da più storici come “uno dei più pericolosi comandanti fascisti” del bolognese e grande ‘cacciatore’ di civili da spedire nei lager nazisti. Venne preso dai partigiani della squadra ‘Temporale della 7 Brigata Garibaldi GAP Gianni’ il 28 agosto 1944 sulla strada per San Giovanni in Persiceto, con lo scopo di ‘scambiarlo’ con 10 loro compagni detenuti in quel tempo nel carcere di San Giovanni in Monte, prima che partissero verso i lager del nord. La trattativa di scambio però fallì quasi subito e venne così ucciso e abbandonato in piazza VIII Agosto a Bologna. Il ten. col. Vetuschi, suo stretto collaboratore, invece morì in uno scontro a fuoco in un’altra azione partigiana, sempre in città, lo stesso 29 agosto 1944.
L’uccisione dei due alti funzionari di Salò poteva provocare un effetto ‘tsunami’ nella Resistenza bolognese incentivandone la lotta. I Vertici decisero così di correre subito ai ripari e lanciare un messaggio a tutti. Del resto, la frase “Dove siamo noi, la giustizia la facciamo noi” era già famosa nel mondo fascista e non solo da parte dell’ideatore, il gen. Mario Robotti, a cui correttamente va il brevetto.
Il comandante della Compagnia autonoma speciale – il cap. Renato Tartarotti – avuto l’ok del padrone nazista (il comando SS di Bologna) fece subito prelevare dalle carceri di San Giovanni in Monte, all’alba del 30 agosto 1944, 12 prigionieri. Documenti – come i registri matricolari d’uscita – certificano che ben 7 (Cesare Zanasi, Arturo e Celestino Garagnani, Alfonso Schinolfi, Giocondo Musi, Luciano Nanni, Renato Bentivogli) erano stati già arrestati dall’Ispettorato regionale per l’Emilia Romagna della GNR nella settimana precedente, due (Luciano Bracci e Renato Sordi) qualche giorno prima dai nazisti delle Waffen – SS Aussenkommando Bologna Sipo-SD, mentre di altri 3 (Floriano Atti, Agostino Pietrobuoni e Gaetano Bussolari) non risultano presenze nei registri matricolari del carcere, ma molti confermerebbero che già da vari giorni fossero in prigione.
Va detto peraltro che Gaetano Bussolari (Maronino) era a Bologna alquanto noto come antifascista da sempre e grande studioso della storia bolognese. Giocondo Musi, invece, era il comandante partigiano della 1a Brigata “Irma Bandiera” e Agostino Pietrobuoni, il capo della zona di S. Agata Bolognese. Suo fratello Quinto, ex garibaldino di Spagna, era appena stato fucilato sempre dalle brigate nere pochi giorni prima, nella piazza di Sant’Agata, davanti alla popolazione. Documenti, in definitiva, provano che non erano diretti responsabili delle due uccisioni. Ma serviva? Serviva? “Dove siamo noi, la giustizia la facciamo noi”.
I 12 vennero così portati in camion presso il Poligono di tiro di via Agucchi e immediatamente fucilati da un plotone di esecuzione, composto da agenti della CAS, al comando del cap. Renato Tartarotti e alla presenza del federale del Fascio di Bologna Pietro Torri e del ten. Bruno Monti (UPI GNR). Ad assistere spiritualmente i condannati a morte fu chiamato don Luciano Gherardi , allora giovane cappellano di 25 anni dell’Ospedale di Sant’Orsola e futuro storico della strage di Marzabotto/Monte Sole.
A guerra finita con sentenza n. 27 del 4/07/1945 il Tribunale competente giudicherà i colpevoli. Il cap. Tartarotti ammetterà di aver prelevato i 12 prigionieri dal carcere e di averli condotti al Poligono di tiro, ma negherà tassativamente di aver partecipato al plotone di esecuzione. Le sue dichiarazioni saranno, un secondo dopo, smentite da altri coimputati presenti all’eccidio (il cap. Gamberini suo braccio destro, in primis). Verrà così condannato a morte e fucilato il 2 ottobre 1945, sempre anch’egli presso il Poligono di tiro di Bologna.
Bruno Monti, il tenente dell’UPI dell’Ispettorato regionale della GNR, accusato in concorso alla fucilazione del 30.08.1944, sebbene riconosciuto colpevole, verrà condannato alla pena di morte mediante fucilazione, ma la Corte di Cassazione con sentenza del 31/05/1946 disporrà l’annullamento e lo rinvierà alla Corte di Modena. Il mese dopo lo salverà l’amnistia Togliatti del Governo De Gasperi. Poi il silenzio di tutti.
Un giorno Andrea Pennacchi (Pojana, per gli amici) – figlio di un ragazzo di 17 anni ‘rastrellato’ nella bassa padovana, mentre lavorava nei campi, dai fascisti di Salò e dai nazisti, nell’estate ‘44 e finito ad Ebensee, sottocampo di Mauthausen – con la sua nota maestria, un giorno disse che a guerra finita ‘a parlare furono solo chi doveva tacere’ e per contrasto inevitabile ‘a tacere furono relegati chi doveva invece parlare’. Sta succedendo ancora oggi.
Molto spesso chi urla dovrebbe fare silenzio, chi tace dovrebbe invece gridare, ai quattro venti, quel che è avvenuto in Italia in quegli anni, quando un regime di violenza e illegalità, diventato governo, ci ha portato ad una guerra fratricida, priva di regole e di dignità. Ma da noi, in Italia, la Storia resta oggi un optional poco gradito. Ed è preoccupante. Malcon X scriveva suo tempo che ‘La storia è la memoria di un popolo e, senza memoria, l’uomo è ridotto al rango di animale inferiore’.
A chi giova non parlarne? Chi ha interesse a nascondere oggi la Storia? Anche quella – perchè no? – dei 12 fucilati al Poligono di Bologna del 30 agosto ’44 mentre altri 5.000 bolognesi venivano in quel tempo rastrellati e spediti nei lager di Hitler, ad arricchire il Terzo Reich, grazie alla collaborazione dei fascisti di Salò.
Chi veniva fucilato e chi rastrellato, al suono triste del “Dove siamo noi, la giustizia la facciamo noi”.
30 agosto 2022 – Rinaldo Battaglia
liberamente tratto da “Alla sera mangiavamo la neve” – ed. AliRibelli – 2022 e pagine del prossimo mio libro “L’inferno è vuoto”