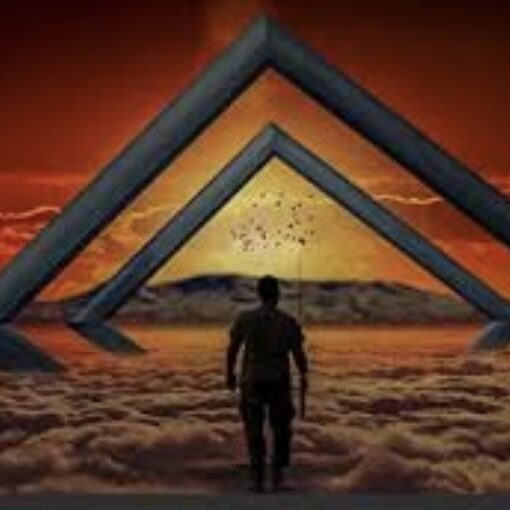DI MICHELE MARSONET

La scomparsa, peraltro attesa, di Joseph Ratzinger all’età di 95 anni, è indubbiamente una grave perdita per la Chiesa cattolica e per l’intera cristianità. Ebbe il coraggio di ritirarsi quando sentì che le forze gli mancavano, e diventò quindi “Papa emerito”, titolo anomalo per il soglio pontificio.

Papati complementari
Molti hanno voluto vedere una contrapposizione tra lui e il suo successore argentino Jorge Mario Bergoglio, eletto pontefice nel 2013 assumendo il nome di Papa Francesco.
In realtà, non tanto di contrapposizione si tratta, quanto di diversità. Benedetto XVI era, innanzitutto, un filosofo e teologo molto raffinato, autore di saggi ormai diventati classici nei quali la sua grande cultura si esprimeva in pieno.
Dal teologo al pastore
Bergoglio invece, sin dai tempi in cui era arcivescovo di Buenos Aires, è sempre stato più attento alla dimensione pastorale del magistero pontificio. Ciò non significa che filosofia e teologia gli siano indifferenti. Più semplicemente, ritine che in un’epoca come la nostra la Chiesa debba aprirsi al mondo usando un linguaggio quanto più semplice possibile.
Ciò spiega il diverso atteggiamento pubblico dei due Papi. Riservato e quasi timido Ratzinger, comunicativo e audace Bergoglio. A Joseph Ratzinger va ascritto il merito di aver riportato al centro dell’attenzione l’insegnamento più tradizionale della Chiesa cattolica.
Tra fede e ragione
Insisteva, in particolare, sul rapporto necessario (e fecondo) tra fede e ragione, riprendendo quindi il classico insegnamento tomistico in tempi che vedono un divario irrimediabile tra fede e ragione.
Molti autori, anche cristiani, ritengono che la fede non possa avere fondamenti razionali, e aprono così le porte a varie forme di irrazionalismo, spesso travestito da misticismo.
Per Benedetto XVI, al contrario, fede e ragione si fecondano a vicenda e la prima non può fare a meno della seconda, tesi espressa al meglio da Tommaso d’Aquino.
Le differenze Ratzinger-Bergoglio
La differenza tra Ratzinger e Bergoglio si coglie inoltre nel diverso atteggiamento nei confronti delle altre religioni. Entrambi attenti alla pacificazione degli animi, soprattutto in relazione ai rapporti con l’Islam, Francesco dà talora l’impressione di preferire il compromesso alla battaglia. Di Benedetto XVI è invece rimasta famosa la “lectio magistralis” che egli tenne, in veste di professore in visita, all’università tedesca di Ratisbona (Regensburg) il 12 settembre 2006.
Filosofo prima che teologo
In quella sede Ratzinger parlò innanzitutto da filosofo, e solo in modo mediato come teologo. Lo spunto fu un dialogo avvenuto nel 1391 tra l’imperatore bizantino Manuele II Paleologo e un dotto persiano su cristianesimo e Islam e sulla verità di entrambi.
Nessuno avrebbe immaginato che un argomento così “dotto”, tipico delle aule universitarie, avrebbe scatenato polemiche a non finire. Tuttavia questo accadde.
Manuele II Paleologo
Ratzinger citò alcune affermazioni di Manuele II Paleologo circa il tema della jihad (guerra santa), notando che non vi deve essere alcuna costrizione nelle cose di fede. L’imperatore bizantino conosceva però anche le disposizioni del Corano circa la stessa guerra santa, e rivolse. al suo interlocutore l’invito a condannare ogni commistione tra religione e violenza, giacché la diffusione della fede mediante la violenza è cosa irragionevole.
Le reazioni del mondo islamico furono piuttosto violente, ma Ratzinger non ritrattò mai, limitandosi a dire che il suo era un discorso filosofico e teologico. E ribadì la convinzione che agire contro la ragione sia in contraddizione con la natura di Dio,
Senza paura delle polemiche
Questo per dire che Papa Ratzinger, per quanto schivo e riservato, non aveva paura delle polemiche. A Francesco alcuni rimproverano di non essere altrettanto chiaro circa i rapporti con l’Islam, senza però tener conto del suo approccio assai differente.
In ogni caso chi scrive è convinto che in futuro Benedetto XVI verrà ricordato e studiato come un grande pontefice, in grado di illuminare l’attività pastorale con la sua profonda sapienza filosofica e teologica.
Articolo di Michele Marsonet, dalla redazione di

31 Dicembre 2022
___________________________________________
![]()